Di Anna Ferrigno
Sarà che siamo giunti in Basilicata col sole a picco sulla testa e un po' accaldati, ma l'arrivo a Matera non è stato affollato. La città ci ha accolto in una profonda solitudine. Per un attimo abbiamo rivisto l'atmosfera estiva delle grandi città deserte e in fuga sulla Salerno Reggio Calabria per mete molto più balneari. In compenso i famosi Sassi lasciano senza fiato.
La loro vista da lontano e da quelle micro-piazzette belvedere, poste lungo il corso principale, dà solo un assaggio di ciò che sono e che rappresentano queste case, costruite nelle pietre, per i lucani: un passato ben radicato nella coscienza contadina di un popolo che riusciva a vivere, crescere e partorire in una casa sovraffollata e larga poco più di un monolocale. Sì, perché i Sassi da vedere sono affascinanti – tutta la Basilicata lo è – ma da viverci, con le comodità a cui siamo abituati, lasciano perplessi. Ci si chiede come fosse possibile che fino al '54, fino a quando Alcide De Gasperi non firmò la Legge Speciale per lo sfollamento dei Sassi, a Matera si vivesse ancora nelle grotte. Dopo quest'atto, i famosi Sassi furono abbandonati e le famiglie si spostarono in case più confortevoli fatte costruire a valle del centro storico.
Eppure quelle abitazioni che vennero definite “una vergogna per tutta la nazione” dallo stesso De Gasperi durante un comizio proprio a Matera, sono il primo esempio di casa ecocompatibile che l'Italia conosce. Perfino nel ricco e profondo Nord, non c'era nulla di paragonabile per efficienza e astuzia umana. I Sassi possedevano un intelligente sistema di raccolta delle acque piovane. Le piogge andavano dritte in una cisterna posizionata sotto il Sasso. Con un piccolo pozzo interno era come avere l'acqua corrente direttamente in casa senza pagare le spese per l'acquedotto. Gli animali, di solito un asinello o un cavallo, vivevano nel Sasso insieme coi padroni e i loro escrementi non venivano buttati ma accatastati in un piccolo vano, ricavato sempre nel Sasso, con funzioni di caldaia per i mesi invernali, particolarmente freddi in questa zona d'Italia. I letti, le tavole, le cassapanche avevano tutte doppie funzioni. Si aprivano e si chiudevano a seconda dello spazio necessario in casa. I Sassi potevano essere abitati anche da una famiglia di 11 persone.
È chiaro che quando Carlo Levi passò per Matera scoprì un mondo – per alcuni versi estremamente affascinante –, ma totalmente lontano da quel minimo di servizi e di pulizia che la modernità offre e un buon governo deve assicurare. Per lui Matera era profondamente e radicalmente lontana da Napoli, Roma, Milano. Ma ignorò il fatto che i Sassi erano stati sfruttati e adattati dall'uomo primitivo molto tempo prima dell'avvento delle case. E che i nostri antenati lì vi avevano trovato rifugio, ristoro e crescita personale fin dalle epoche più remote. La natura aveva offerto, gratuitamente – e per molti secoli lo farà ancora – ciò che un Governo non era – o non è – capace di offrire oggi con le case popolari. I Sassi hanno forgiato il carattere e la personalità di un popolo che non conosce il sapore acro dei sacrifici perché abituato a partorire nel 'dolore'. Il solo fatto di crescere in Basilicata rende la personalità più forte. Il paesaggio brullo, il sole cocente, la mancanza di grandi fumi e sorgenti hanno reso la vita non certo facile ai lucani. Eppure la gente si è adattata, ha costruito, ha sfruttato, senza distruggerlo, un posto meraviglioso per natura. Il tutto mai con un lamento. Non credo che l'Italia conosca i lamenti lucani. Le difficoltà lavorative. La fuga delle giovani generazioni. Perché qui la gente non grida, non urla.
Attualmente sui Sassi campeggia la scritta “proprietà del demanio” ed è facile domandarsi quando saranno battuti all'asta. Spulciando fra le carte di un passato non certo lontano abbiamo rintracciato che l'ex sindaco di Matera, il senatore Nicola Buccino presentò, nel 2007, un emendamento in Finanziaria per trasferire alcune proprietà demaniali dei Sassi al Comune a titolo gratuito. L'atto parlava chiaro: “Il Comune è autorizzato, nell’atto di cessione, ad alienare a titolo oneroso questi immobili ai medesimi sub-concessionari (solitamente privati, ndr), alle condizioni di aver conservato la destinazione d’uso dei beni ed aver rispettato tutti gli altri vincoli di legge e di contratto. I privati acquirenti, inoltre, dovranno impegnarsi a conservare anche dopo l’acquisto la destinazione d’uso degli immobili. Le risorse finanziarie rivenienti dalla vendita degli immobili saranno utilizzate dal Comune solo ed esclusivamente per effettuare interventi di conservazione e recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico nei Rioni Sassi e per dare impulso alle attività turistiche e commerciali ivi ubicate”.
In realtà tutte queste infrastrutture non le abbiamo viste. Sta di fatto che lasciando il percorso riservato ai turisti i Sassi si presentano in un profondo stato di abbandono, con rifiuti buttati lungo le scale, erba cresciuta ovunque e impalcature lasciate lì da anni. C'è da chiedersi che fine faranno i Sassi di Matera. Che fine farà una delle città più antiche al mondo, dal 1993 Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Che ne sarà di tutta quella storia?
Da dazebao.org
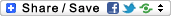
Recent comments
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago
12 years 17 weeks ago