Anche per l’Umbria la ripresa economica si gioca sui caratteri, la qualità e le scelte delle politiche industriali. La crisi ha infatti fortemente accentuato criticità e debolezze del sistema regionale, esponendolo a rischi correnti, soprattutto nei settori legati all’export, alla internazionalizzazione e all’innovazione. E’ quanto emerge dal Rapporto MET (Monitoraggio Economia e Territorio) 2009, “Imprese e politiche in Umbria, la crisi e i cambiamenti nelle strategie di crescita” illustrato stamani, a Perugia, dal presidente MET Raffele Brancati.
Lo studio, basato su “interviste” realizzate tra il 2008 e il 2009 da un apposito gruppo di lavoro, ha riguardato un campione di 1100 imprese umbre, nell’ambito di una più vasta indagine che, in tutto il territorio nazionale, è stata estesa a 47 mila aziende. Alla presentazione della ricerca, promossa dall’Agenzia Umbria Ricerche (AUR), hanno partecipato tra gli altri il presidente ed il direttore di AUR, Claudio Carnieri ed Anna Ascani, e l’assessore regionale allo sviluppo economico Gianluca Rossi. I lavori sono stati conclusi dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.
Secondo il Rapporto segni premonitori della imminente grande crisi erano già presenti nell’industria nel 2008, dopo quella che in Umbria era stata una positiva fase espansiva nel triennio 2004/07. In quel periodo il Pil umbro si mostra in linea con quello nazionale, mentre il Vai (valore aggiunto industriale) cresceva dell’1,3 a fronte di un +05 nazionale. Lo studio smentisce la tesi di una crisi, in un certo senso “salutare”, cioè destinata a colpire aziende di per sé deboli o instabili. Al contrario, a subire i maggiori danni sono state le imprese con programmi di crescita e sviluppo, “bloccati” dalla contrazione della domanda di mercato.
Ad essere colpite soprattutto le attività di ricerca e innovazione, con una riduzione delle imprese innovative, campo nel quale l’Umbria ha offerto, però, una risposta superiore alla media nazionale. Le imprese che in Umbria mostrano maggiore propensione all’innovazione sono quelle della carta, stampa, editoria, macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche, mentre più arretrate sono le aziende per la fabbricazione dei mezzi di trasporto e quelle della filiera dell’abbigliamento. A soffrire l’export, i processi di internazionalizzazione e, in relazione all’ambito dimensionale, le imprese più grandi che hanno subito effetti negativi soprattutto nei loro rapporti col sistema creditizio e nella capacità di fare investimenti.
Per il Rapporto “l’arretramento delle quote d’export regionale nel periodo 2008-2009 sembra essere quasi esclusivamente imputabile a un effetto competitività molto negativo”. Viene inoltre messa in evidenza la forte e progressiva diminuzione negli anni dal 2002 al 2008 delle risorse pubbliche destinate alle politiche industriali (-83%). L’Umbria si muove in netta controtendenza in questa situazione e l’incidenza delle risorse regionali sui fondi per politiche industriali è giunta in Umbria alla percentuale del 38%, a fronte di una media nazionale delle altre Regioni del 10. Esiste quindi, innanzitutto, l’esigenza dell’incremento delle risorse pubbliche nazionali, dal momento che sarebbe illusorio poggiare solo su quelle regionali.
Le politiche industriali e gli incentivi in Umbria sono stati principalmente rivolti a sostenere l’innovazione e i processi costitutivi di reti di impresa. Su questa strada occorre proseguire, puntando a “far acquisire alle pubbliche amministrazioni ancora di più la capacità di prospettare e realizzare iniziative innovative ‘facendo sistema’, al fine di massimizzarne l’efficacia”.
Dal Rapporto – hanno evidenziato Claudio Carnieri ed Anna Ascani - emerge con nettezza come gli effetti negativi della crisi si siano determinati soprattutto nei settori maggiormente esposti alla competizione internazionale, mentre inizialmente essi sono stati meno rilevanti nei settori prevalentemente orientati al mercato interno. Le conseguenze negative si sono manifestate con particolare forza nei confronti di aziende che avevano in corso programmi di crescita e di investimento al momento dell’esplosione della crisi. L’indagine conferma inoltre come la crisi ha accelerato o appesantito situazioni già compromesse prima del settembre 2008.
Secondo l’assessore regionale allo sviluppo economico, Gianluca Rossi “se si vuole arginare il graduale declino dell’economia italiana che, in futuro, potrebbe addirittura pregiudicare la partecipazione del nostro Paese all’Europa dell’Euro, è necessaria una stagione nuova di politiche industriali”. Per Rossi la politica industriale deve puntare, con tutti gli strumenti a sua disposizione, “a favorire un rilancio della dinamica del sistema produttivo, con una decisa azione pubblica nel campo degli investimenti in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie”, anche per “sviluppare la produzione di beni e servizi più avanzati che l’attuale struttura produttiva sembra non essere in grado di realizzare”.
Contrariamente al resto delle principali economie europee, in Italia – secondo l’assessore, “manca una visione compiuta sulle possibili strategie di supporto alle imprese, di cui il capovolgimento della posizione italiana nella graduatoria europea degli aiuti è uno degli aspetti tangibili. Negli ultimi 12 anni – ha ricordato, l’Italia è passata dall’essere uno dei Paesi maggiormente erogatori di aiuti di Stato al fondo della graduatoria. Tra il 1996 e il 2007 gli aiuti europei (area euro) in rapporto al Pil sono diminuiti del 50,47%, passando da un’incidenza dell’1,05% ad una dello 0,53%, mentre in Italia lo stesso rapporto è passato dall’1,20% allo 0,33%. Lo stesso apparato produttivo sembra essere poco reattivo rispetto agli interventi indotti dalle politiche di sostegno che di fatto non vanno a modificare caratteristiche e limiti del sistema produttivo. E’ il caso delle misure per la ricerca sviluppo e l’innovazione che non hanno corretto la bassa entità di spesa in R&S che caratterizza l’intero sistema produttivo (nel 2007 lo 0,55% del Pil, contro una media dei paesi di area euro pari a 1,19%). Ciò perché la struttura della specializzazione produttiva del sistema industriale italiano si caratterizza per scarsa la presenza di settori ad alta intensità tecnologica, mentre è numerosa, è il caso anche dell’Umbria, quella di settori tradizionali con imprese di piccole e piccolissime dimensioni, la cui più bassa propensione di spesa in R&S condiziona la massa critica della spesa di tutto il sistema produttivo”.
“Occorre invece – ha concluso Rossi – una concezione di uno Stato che assicuri e sostenga il buon funzionamento del mercato e che è in grado d’intervenire concretamente a supporto delle imprese per favorirne lo sviluppo, la creazione di nuove, con misure di sostegno solo nei contesti di crisi reversibili”.
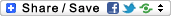
Recent comments
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago
12 years 11 weeks ago