di Fulvio Lo Cicero per Dazebao.org
Josè Saramago è morto oggi a Tias (Spagna) ad 87 anni, essendo nato il 16 novembre del 1922 in un paesino a cento chilometri da Lisbona, Azinhaga. Figlio di un contadino poverissimo, a tre anni la famiglia si trasferisce nella Capitale, dove il padre trova un lavoro come poliziotto. Ancora molto piccolo, Josè deve abbandonare gli studi per aiutare la famiglia a tirare avanti.
Sono esperienze che lo segneranno profondamente dal punto di vista politico. Nel 1969 si iscrive al partito comunista, in quel tempo clandestino e riesce sempre a sfuggire alla polizia del regime fascista. Nel 1947 pubblica la sua prima opera “Terra do pecado” dopo la quale segue un silenzio di trent’anni durante i quali lavora come assicuratore , dirigente editoriale, giornalista. Fino alla metà degli anni ’70 vive un intenso periodo di formazione, scrive poesie e riflessioni. La “rivoluzione dei garofani” e la cacciata dei fascisti dal Paese, con la fine della sanguinaria dominazione coloniale in Africa, sembrano liberare anche le energie artistiche di Saramago. Con “Memoriale del convento” (1980) arriva il grande successo di pubblico, seguito da “L’anno della morte di Riccardo Reis”, un omaggio a Ferdinando Pessoa. I romanzi successivi lo consacrano sulla scena internazionale: “Il vangelo secondo Gesù”, “Cecità”, “Tutti i nomi”, “La caverna”, “L’uomo duplicato”, “Le intermittenze della morte”, “Le piccole memorie”. Nel 1998 riceve il premio Nobel ed è il primo portoghese a conquistare l’ambito premio dell’Accademia svedese. Nel 2009, l’ultima polemica italiana. Einaudi si rifiuta di pubblicare “Il quaderno”, una sorta di taccuino in cui lo scrittore denuncia le malefatte di Berlusconi. Lui cambia editore e i suoi pensieri sul premier italiano saranno pubblicati da Bollati Boringhieri.
*** *** ***
Confesso di aver amato lungamente Josè Saramago, di essere maturato con i suoi libri e con quelli di Gabriel Garcia Marquez, di Gunther Grass, di Italo Calvino, di Leonardo Sciascia. Per un semplice lettore come me, Saramago ha rappresentato l’archetipo dello scrittore novecentesco, un cultore dei sogni (e spesso degli incubi) di un secolo drammatico, insidioso, scosceso fra le grandi utopie e le grandi sconfitte.
La lettura di Saramago non era mai piacevole. Lui presentava storie al limite, scorgendo nella realtà una concrezione entro cui difficilmente si poteva penetrare. Lo scrittore portoghese era convinto della illogicità del mondo, concepito come una sorta di gabbia dove si affastellano le ombre di esseri umani inconsapevoli e, come in un famoso dipinto di Peter Bruegel il vecchio, destinati a precipitare nel vuoto. Per questo, alcuni suoi percorsi narrativi ricordavano Pirandello, anche se il suo stile, a differenza del grande siciliano, era allucinato, a volte persecutorio. Tratto essenziale ne era la costruzione del racconto senza “a capo”, con le frasi pronunciate dai protagonisti che si susseguono l’una dietro l’altra senza virgolette, come in un flusso di coscienza joyciano.
Per la generazione che si formò negli anni Ottanta del secolo scorso, Saramago fu il contraltare di Jorge Luis Borges, al quale si rifacevano indubbiamente le sue ispirazioni da realismo magico. Ma, mentre in Borges non riuscivamo a trovare una risposta politica, essendo il grande argentino un uomo sostanzialmente di destra, convinto dell’efficacia sociale della gerarchia militare, in Saramago potevamo specchiarci fino in fondo. Lui era un convinto comunista; ha creduto fino al giorno della sua morte nella ineluttabilità della rivoluzione. Odiando il capitalismo e i rapporti sociali che ne derivano, Saramago ha sempre ritenuto che soltanto la dottrina comunista fosse in grado di fornire una risposta valida al dramma della povertà e delle ingiustizie.
In uno dei suoi romanzi migliori, “Cecità” (1995), egli racconta che in una città indeterminata, un certo giorno indeterminato, tutti gli abitanti diventino ciechi ad esclusione della moglie dell’oculista, che continua a vedere pur fingendo il contrario. I ciechi sono rinchiusi in un moderno lazzaretto, dove subiscono ogni forma di persecuzione e sono preda di una pandemia mortale. Poi le porte si aprono e tutti, magicamente, riacquistano la vista. Ma è una falsa vista e la moglie, vera protagonista della storia, dice: «Perché siamo diventati ciechi? Penso che non siamo diventati ciechi. Ciechi che vedono, ciechi che vedendo non vedono». Proprio questo romanzo inaugura il secondo e ultimo periodo di Saramago, quello in cui – è lui stesso a confermarlo – inizia il suo “scavo dall’interno” del mondo, dopo aver dedicato la sua attenzione soprattutto alla materia storica portoghese.
L’altra perla della sua produzione è senza dubbio “Tutti i nomi” (1997), dove il vero protagonista è la Conservatoria Generale dell’Archivio Civile e un suo anonimo impiegato, don Josè che conosce ogni piccolo meandro di quegli spazi, dove convivono i vivi e i morti. Egli vive nell’ossessione di ricopiare nomi e fatti di cui si appropria nel suo ufficio per ricopiarli a casa, fino al giorno in cui scopre il nome di una donna di 36 anni, una perfetta sconosciuta, che da quel momento diventa l’apice della sua ossessione e lo porterà rapidamente alla rovina. Come sottolinea Manuel Vàzquez Montalbàn, «nei suoi percorsi nell'intento di costruzione di una donna reale, don Josè la sta decostruendo, perché l'indagine lo porterà alla morte, all'interno dei due emisferi separati della Conservatoria dei Registri, quello dei morti e quello dei vivi». Un romanzo, allo stesso tempo, pirandelliano e borgesiano, dove sono racchiusi praticamente quasi tutti i temi dello scrittore portoghese: l’insanità del reale, l’apparenza, la finzione sociale, le aporie dei rapporti umani, la morte. In effetti, proprio quest’ultima ricostruisce ogni scenario possibile in Saramago, una morte fisica, che non aspira a diventare conquista religiosa, ovvero a scavalcare l’eternità del tempo (un concetto a lui sostanzialmente estraneo).
La fede è un altro punto nodale della costruzione artistica di Saramago. Nel “Vangelo secondo Gesù”, del 1991, lo scrittore portoghese racconta la vita del fondatore del cristianesimo nei suoi termini realistici e fa di lui un personaggio in carne ed ossa, depurato da ogni costruzione mitologica e fideistica. Di Gesù viene colto soprattutto il suo rapporto con un Dio inconoscibile, perfino crudele, come nella tradizione dell’Antico Testamento. Il romanzo suscitò accese critiche da parte del mondo cattolico e fece di Saramago un avversario della fede. Lui, più volte, dichiarò di non avere alcuna stima del Vaticano, che è «semplice amministratore della fede».
Convinto fino alla fine dell’irrealtà del reale, Saramago è stato soprattutto il fedele cronista di ciò che gli occhiali della contemporaneità nascondono. Per questo, la sua narrativa ha rappresentato, forse, nel Novecento il tentativo più coraggioso di penetrare la vita sociale nei suoi aspetti misteriosi e inconoscibili. Una letteratura “politica”, sul modello indicato da Kafka o da Elias Canetti, una rappresentazione teatrale crudele che non lascia scampo al lettore. E che proprio per questo lo colloca ai vertici della letteratura mondiale.
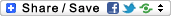
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago