da
www.socialismo2000.org
L’idea di cambiare l’articolo 41 della Costituzione continua a essere proposta dal governo ed è stata accolta con entusiasmo dalla Confindustria. Non basta rispondere che è un pretesto e che è possibile fare tutte le semplificazioni di cui si parla senza cambiare la Costituzione, come pure è stato spiegato in questi giorni da autorevoli giuristi. L’idea di Tremonti si inserisce infatti in un’offensiva ideologica e in tendenze istituzionali in atto da un certo tempo nell’Occidente.
Occorre fare un passo indietro. Negli ordinamenti giuridici ottocenteschi la proprietà era considerata un diritto fondamentale inviolabile, alla pari dei diritti di libertà. Fu nel secolo scorso che l’endiade proprietà-libertà fu rotta a livello di principio, e la proprietà fu tolta dal catalogo dei diritti fondamentali. In Italia, con la Costituzione del 1948, che comprende, accanto all’articolo 41, il principio della funzione sociale della proprietà privata nell’art. 42. Ma non solo in Italia.
Quando Berlusconi, e non solo lui, parla di ispirazione “catto comunista” dei nostri principi costituzionali in materia, mostra di ignorare che principi analoghi furono introdotti nella Costituzione tedesca del 1947, nel nuovo preambolo alla Costituzione francese, e nella Costituzione che la Spagna si diede dopo il superamento della dittatura franchista. Negli Stati Uniti d’America, fino agli anni ‘30 la Corte Suprema interpretava la Costituzione secondo i principi del liberismo, cassando ad esempio le leggi che ponevano limiti agli orari di lavoro. Un’aspra battaglia culturale, condotta in prima persona dal presidente Roosvelt provocò un profondo cambiamento di indirizzo.
Dal 1937, la Corte Suprema adotta il criterio del “doppio standard”: per i diritti civili, massime garanzie; per le libertà economiche, invece, la prevalenza è assegnata alle scelte del legislatore. In un famoso discorso, Roosvelt enunciò le quattro libertà alle quali doveva ispirarsi il mondo che usciva dalla guerra antifascista. C’era la libertà dal bisogno, non la libertà economica. A questi stessi principi si ispirò la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Onu nel 1948.
Fu un cambiamento epocale dei principi costitutivi degli ordinamenti giuridici occidentali: la premessa di quell’età dell’oro nella quale fu raggiunto un compromesso tra libertà economica e affermazione dell’interesse generale e dei diritti sociali, tra crescita e occupazione.
Da tempo un movimento è in atto per il ritorno all’equazione ottocentesca tra proprietà e libertà. Negli Stati Uniti d’America il movimento neocostituzionalista si batte perché la giurisprudenza della Corte Suprema torni ai principi di 100 anni fa. In Europa le punte di diamante di questo orientamento sono le due corti di giustizia. La Corte dell’Unione Europea in più di una decisione, a partire dai casi Viking e Laval, ha affermato che le libertà economiche previste dal Trattato prevalgono sui diritti sociali e sulla legislazione del lavoro. La Corte dei diritti umani con sede a Strasburgo, a sua volta, negli ultimi anni ha posto il principio che in caso di espropriazione o di limiti considerati eccessivi il proprietario deve essere indennizzato in base ai valori di mercato: un criterio abbandonato nella legislazione italiana da oltre un secolo e negato in sessant’anni di giurisprudenza dalla nostra Corte Costituzionale. La Carta di Nizza della U.E. purtroppo va nella stessa direzione: libertà di impresa e proprietà privata sono garantite senza alcun riferimento alle clausole sociali.
Il neocostituzionalismo è la teoria giuridica del neoliberismo. La libertà economica è di nuovo equiparata ai diritti personali di libertà, l’intervento dello Stato è possibile solo in casi eccezionali e specifici, le Corti devono decidere se il legislatore ha ecceduto nei suoi interventi, in ogni caso chi è colpito da questi limiti ha diritto a vedere il suo patrimonio reintegrato a spese dello Stato.
Giulio Tremonti, uomo di molte letture, queste cose le sa. Silvio Berlusconi intuisce che su queste basi può costruire una piattaforma di rilancio del blocco sociale e dell’ideologia del PDL nella seconda fase della legislatura. Non si tratta a mio avviso di battute episodiche. La dimensione sociale è un tratto costitutivo della nostra democrazia.
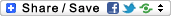
Monday
14/06/10
09:27