Nella discussione su Craxi statista si perpetua l’incapacità di definire il nesso tra responsabilità politica e giudiziaria. Nesso nella cui lettura si oscilla, a seconda delle contingenti necessità, dalla totale identificazione (la richiesta di dimissioni del politico o dell’amministratore “colpito” dall’informazione di garanzia) alla totale negazione. Quest’ultima è a volte giustificata sulla base di una cattiva lettura dell’autonomia tra politica e morale, che non implica affatto indifferenza ai valori e al rispetto delle regole, ma solo (ed è un “solo” che vale secoli di storia) che queste ultime non si identificano con i primi (le regole morali non sono di per sé coercibili). Con la lettura delle vicende di Craxi questo circolo vizioso si chiude clamorosamente. Scindere il Craxi politico dal Craxi “criminale”, per richiamare un’intervista dell’allora segretario del Pd Pietro Fassino, può esser fatto solo a rischio di perdere una parte consistente degli elementi esplicativi di quella stagione politicoistituzionale.
Ciò non vuol dire negare i grandi meriti che Craxi ebbe, nell’individuare la necessità di una profonda trasformazione del Paese, a partire da un confronto da pari a pari con il Pci, come ha messo in luce da par suo Mario Pirani (La Repubblica, 4 gennaio 2010), senza per questo dimenticarne gli altrettanto grandi limiti. Vuol dire invece interrogarsi sulla correlazione tra le modalità con le quali quella politica fu gestita e la diffusione del sistema delle tangenti. Ciò potrebbe forse dare risposte al presente molto più interessanti della polemica sulla toponomastica o sui Pantheon della sinistra.
Davvero si pensa che il ferreo controllo sulle risorse finanziarie del Partito, in parte derivanti da reati, sia estraneo al ferreo controllo sulla struttura del partito, a sua volta condizione del ruolo svolto da Craxi nella politica italiana degli anni ’80? Tale questione è centrale per comprendere, almeno in parte, la trasformazione del partito politico fino ai nostri giorni. Certo, il successo della politica craxiana era stato sanzionato dalla vittoria elettorale del 1983. Sarebbe dunque un grave errore ridurre la politica alle vicende giudiziarie.
Ma il ruolo che il finanziamento ebbe nel confronto interno al partito (vedi affari Eni-Petronim e Banco Ambrosiano) non è questione che possa esser trattata come mero accidente, quasi parentesi nelle vicende di quel partito. Non vi è dubbio che il sistema delle tangenti ebbe in quegli anni una diffusione assai maggiore che in passato, tanto che la quantità si trasformò in qualità: dalle indagini svolte in tante sedi diverse emerse una realtà impressionante, di corruzione diffusa dal livello più alto a quello più basso della politica e dell’amministrazione, con
un aumento esponenziale di costi e tempi delle opere pubbliche.
Il famoso discorso di Craxi dinanzi al Parlamento (3 luglio 1992), nel quale egli affermava che il finanziamento illecito dei partiti non riguardava solo il
Psi ma l’intero sistema politico, non può esser oggi letto come il vaticinio di chi vedeva più lontano. Che la politica abbia dei costi non era cosa nuova.
A parte che non si riesce a comprendere perché la politica in Italia debba costare più che in Francia o in Gran Bretagna, il fatto era talmente noto che nel 1974 era stata emanata una legge che consentiva il più ampio finanziamento legale dei partiti, da parte dei cittadini
e delle imprese, con il solo limite di alcune formalità, sistematicamente violate. Quel discorso mirava dunque
a inchiodare la classe politica a un passato inglorioso.
Non bisogna guardare con rimpianto, quasi come a un’occasione perduta, alla risposta non data a quella chiamata a raccolta. Ci si dimentica oggi che lemonetine dell’Hotel Raphael trovarono la loro causa immediata nella protervia con la quale il Parlamento (a maggioranza, non lo si dimentichi) negò l’autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi per gravi fatti
di reato. L’autorizzazione a procedere si era ormai trasformata da strumento di protezione dell’eletto contro l’ingiusta persecuzione, in strumento di impunità
perfettamente funzionale alla trasformazione del sistema
di autofinanziamento degli uominipolitici.
Quelle vicendedovrebbero esserun monito sugli effetti disastrosidell’autoreferenzialità della politica, da tenere ben presente quando si vogliapor mano a una riforma delle immunità.
La concezione proprietaria e personalisticadel partito, che avviò i profilidi fidelizzazione oggi imperanti, si lega strettamente al rapporto con Roberto Calvi e al finanziamento del Psi di Craxi da parte del Banco Ambrosiano, anche in funzione di lotta interna al partito. In questo quadro il giudizio sul famoso discorso a tutela di Calvi, che apre la stagione dello scontro istituzionale con la “magistratura politicizzata”
non può esser compreso senza il dato giudiziario.
Un aspetto di trasformazione che indiscutibilmente
Craxi ebbe ben chiaro fu il ruolo che avrebbe potuto svolgere la televisione nella competizione
politica. Non è che altri non lo intendessero, ma non seppero rispondere adeguatamente alla nuova sfida. Basti
pensare all’inane tentativo del Pci di opporsi alla televisione a colori. E’ evidente che in questa scelta vi era la consapevolezza dell’invasione nelle vite
dei cittadini di uno strumento di comunicazione ormai non più distinguibile dalla realtà. La risposta, tuttavia, era tragicamente inadeguata, come Giovanni dalle Bande Nere dinanzi alle nuove armi da fuoco.
Comprendere appieno quella intuizione, però, non può prescindere dal legame con l’allora imprenditore Silvio
Berlusconi. Basti leggere la sentenza Mills di primo grado (confermata in appello). Esercizio peraltro che dovrebbe raccomandarsi a tutti coloro che in questi giorni parlano di giustizia e politica. Non si tratta solo di dare un giudizio morale sull’operazione di finanziamento illecito, ma di valutare come si legassero tra loro il disegno politico di controllo del mezzo televisivo e l’elusione delle norme che quel mezzo disciplinavano. Infine, la modernità di Craxi nel disegnare un sistema istituzionale basato sulla responsabilità dell’eletto nel governare si lega inscindibilmente con il rifiuto di qualunque bilanciamento o dell’effettività di un sistema di controlli.
E’ la concezione neo-giacobina della politica, che identifica la democrazia con il potere della maggioranza e che si apre – nel legame con il controllo del partito, degli eletti e dei mezzi di comunicazione di massa – a una lettura populistica e autoritaria del ruolo del leader.
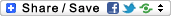
Recent comments
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago