Bettino Craxi, segretario di un partito di sinistra, socialista, introdusse per primo nel sistema politico della Prima Repubblica un nuovo leaderismo, proteso a un rapporto diretto con l'opinione pubblica attraverso un uso accorto, e non di rado spregiudicato, del potere mediatico. Si trattò di scelte destinate ad avere conseguenze enormi per il paese. La loro radice può essere rintracciata in alcune importanti intuizioni culturali e nel tentativo di dare risposte politiche nuove a una società avvertita in rapida trasformazione. Esse però, è inesorabile constatarlo, approdarono a una scelta che, a prescindere dalle intenzioni di Craxi, spianò la strada al populismo mediatico.
La parabola politica di Craxi prese avvio a metà degli anni Settanta. Mentre i principali protagonisti politici, comunisti e democristiani sopratutto, erano ancora immersi nella esperienza e nella cultura dei partiti di massa, egli intuì che si stava aprendo una fase nuova: l'opinione pubblica tendeva a rendersi autonoma dai partiti e stava emergendo un nuovo individualismo di massa. In effetti si stavano susseguendo fatti politici non riconducibili alle vecchie categorie della politica italiana. Nel '74 si era svolto il referendum sul divorzio e i "No" avevano prevalso con percentuali ben superiori a quelle dei partiti divorzisti: era il primo forte segnale di mobilità elettorale della nostra opinione pubblica. Anche le piazze parlavano un linguaggio nuovo: le donne in grandi dimostrazioni di massa chiedevano libertà individuale. Insomma: crescita del soggetto e libertà dell'individuo erano, a ben guardare, i temi emergenti di quella stagione.
La piccola formazione radicale fu la prima a cogliere la novità. Nel nome delle libertà individuali e dei diritti civili i radicali portarono in Parlamento una piccola pattuglia che si muoveva con un linguaggio e con tecniche politiche del tutto nuovi, con la ricerca ostinata e ossessiva del protagonismo mediatico, con una direzione leaderistica. Anche Craxi e il nuovo corso socialista cercarono di interagire con questi umori e con queste sollecitazioni. Il più vecchio partito italiano, in difficoltà elettorali e strategiche, iniziò sotto la guida di Craxi una profonda metamorfosi per confrontarsi con questa "modernità": il Psi si impegnò a fondo per elaborare una nuova cultura politica e per individuare nuovi messaggi e strumenti politici.
Il nucleo portante del nuovo gruppo dirigente socialista aveva le sue radici a Milano, qui aveva visto emergere moda e design, aveva visto dilatarsi i ceti medi e crescere nuove professioni. Per dialogare con queste nuove realtà, si cominciò a pensare, non bastava più l'antico strumento del partito di massa, bisognava spostare l'accento verso i cittadini, verso l'individuo, verso l'opinione pubblica. Venne avviata così una trasformazione destinata a cambiare profondamente il partito e la natura stessa della leadership.
La società moderna, individualista, venne teorizzato, non aveva più bisogno di messaggi pesanti: l'ideologia doveva lasciare il posto al pragmatismo. Il saggio di Craxi su Proudhon, con il quale si esplicitava il conflitto culturale con il Pci, serviva a liquidare il "fardello" dell'ideologia: al suo posto subentrava un riformismo ultrapragmatico. Tempi e natura del messaggio politico cambiavano. Al posto del "sole dell'avvenire", di un'idea di cambiamento proiettata nel futuro, subentrava il modello della "Milano da bere": i messaggi politici si semplificavano, in un mix inedito di concretezza e di disinvoltura, senza più slanci ma neppure remore ideali.
Il problema del nuovo gruppo dirigente craxiano divenne la ricerca di forme e di canali per il rapporto con questa nuova opinione pubblica mobile, inquieta, individualista. Il vecchio partito, legato al mondo del lavoro, strutturato su base territoriale, diviso e rissoso anche perché sede di appassionati dibattiti ideali, appariva inadeguato a questo compito. Le discussioni interne non portavano consensi: all'opinione pubblica servivano messaggi diretti, semplici e chiari. La prima questione da risolvere fu allora la riduzione del partito a docile strumento del leader: il dibattito interno, vivace anche nella prima stagione craxiana soprattutto grazie alla rivista Mondo operaio , venne stroncato. Gli organi dirigenti del partito vennero svuotati, fino alla famosa assemblea dei "nani e delle ballerine" e all'elezione del segretario nazionale per acclamazione. Le scenografie congressuali dell'architetto Panseca erano parte di questa nuova strategia volta ad impressionare l'opinione pubblica, a raggiungerla con messaggi che celebravano le capacità, la forza e il prestigio del leader. Il plebiscito interno era organico alla semplificazione del messaggio.
Questa strategia aveva però bisogno di una robusta presenza sui media: ecco perché tante energie di Craxi vennero assorbite dalla conquista del potere mediatico. Prima preoccupazione furono, ovviamente, i media tradizionali, la Rai e i quotidiani. Da qui l'impegno per la lottizzazione della tv pubblica e l'aspra battaglia per il controllo dei fondamentali organi di stampa. Milano, ancora una volta, era il centro delle preoccupazioni. Mentre si portava Il Giorno in orbita socialista, si infiammava lo scontro per il Corriere arrivando, con la direzione Cavallari, fino alle aule del tribunale.
Ma la vera novità di Craxi fu l'apertura senza indugi e preoccupazioni alle radio e alle tv commerciali. Senza alcuna delle ingombranti remore che paralizzavano in materia i comunisti, Craxi aprì le porte ai nuovi imprenditori mediatici. Si strinse così il rapporto con un immobiliarista milanese, Silvio Berlusconi, da tempo vicino agli amministratori socialisti e ora alla ricerca dei lasciapassare politici per affermare il proprio potere mediatico. Craxi concesse fiducia senza titubanze: il tornaconto politico immediato sembrava enorme, tale da fare accantonare ogni interrogativo su regole, valori, implicazioni di medio e lungo periodo.
Per tenere saldo il rapporto Craxi arrivò a compiere scelte clamorose, destinate a lasciare un segno profondo nella vita pubblica del paese. Berlusconi, in violazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che aveva legalizzato l'emittenza televisiva privata solo per trasmissioni localmente delimitate, cominciò a trasmettere a distanza di qualche secondo l'una dall'altra cassette dei suoi programmi nelle sue televisioni distribuite su tutto il territorio nazionale. In questo modo schiantò la concorrenza delle televisioni private di Mondadori e di Rusconi fino a concentrare nelle sue mani, in un inedito monopolio, tutte le tre principali reti televisive private. Alcuni magistrati tentarono di reagire e di ripristinare il rispetto della legge. Nell'ottobre 1984 tre pretori di Roma, Torino e Pescara oscurarono le televisioni di Berlusconi ingiungendo loro di trasmettere solo programmi locali. A quel punto intervenne Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio: interruppe una visita ufficiale a Londra per fare approvare un decreto che riattivasse le reti Fininvest. Craxi non cambiò mai più questo orientamento. Anche in occasione dell'approvazione della legge Mammi, che sanciva il duopolio Rai-Mediaset, Craxi non arretrò di un passo, nonostante la clamorosa rottura con la sinistra democristiana che arrivò a ritirare i suoi ministri dal governo.
Craxi, leader politico potente, pensava presumibilmente di tenere "naturalmente" sotto controllo il nuovo potere mediatico. L'hubris del leader politico, la presunzione e la tracotanza che non di rado si insinuano nell'esercizio della leadership politica, gli impedivano di vedere che si stava alimentando un nuovo potere destinato a sfuggire ad ogni controllo e a prevalere sugli altri. L'uomo politico, che per la sua strategia aveva un bisogno vitale dei media, non si rese conto che stava alimentando un potere che si sarebbe rivoltato contro la politica e contro i partiti tradizionali. Craxi non avvertì che il rapporto di potere tra media e politica avrebbe potuto ribaltarsi. Accadde così che un leader politico socialista, che aveva sempre tratto legittimazione dal controllo del suo partito, spianò la strada al populismo mediatico. Questo è probabilmente l'estremo paradosso della parabola politica e umana di Craxi.
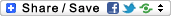
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago
12 years 14 weeks ago