Raffaele Bonanni, postmoderno segretario della Cisl, ha ieri argomentato, con autentico fervore, come la vera riforma di cui il Paese ha prioritario bisogno sia quella di ricostruire il patto fondamentale che lega i cittadini fra loro e fra essi e lo Stato, vale a dire il patto fiscale, la regola - vergata con inequivocabili parole nella Costituzione - secondo cui ciascuno deve contribuire all'erario in misura proporzionale al proprio reddito, attraverso un prelievo che abbia carattere di progressività. La riscoperta di questo imperativo categorico, sotto la sferza della crisi che per tante persone sta assumendo proporzioni drammatiche, è ovviamente benvenuta, ancorché tardiva. Abbiamo più volte insistito, su queste pagine, sulla circostanza, non certo fortuita, che il gravame fiscale - a prescindere dal mastodontico fenomeno evasivo - si è interamente spostato sul lavoro dipendente, su coloro cioè che pagano la ritenuta alla fonte. Che un riequilibrio sostanziale sia necessario è dunque fuori discussione.
Ciò che sorprende, nelle parole di Bonanni, di mestiere sindacalista, è che c'è un altro terreno sul quale egli dovrebbe esercitare - direttamente - un ruolo da attore protagonista nella redistribuzione della ricchezza: è quello negoziale, attraverso il quale, dentro i luoghi di produzione di merci e di servizi, si contratta quanto del valore generato è appannaggio della retribuzione. Qui il conto non torna. Perché la moderazione rivendicativa e il contenimento dei salari sono stati l'alfa e l'omega delle politiche sindacali da oltre vent'anni a questa parte. Sino alla paradossale sottoscrizione - meno di un anno or sono - dell'accordo separato che mette in conto e legittima una scientifica riduzione del salario. Questa pratica deleteria si è sommata ad altri due concomitanti processi, nessuno dei quali è stato mandato dal cielo: da un lato la selvaggia deregolamentazione del mercato del lavoro, portatrice di precarizzazione, cancellazione di diritti individuali e collettivi, sottosalario e voragini previdenziali che le nuove generazioni pagheranno nel tempo; dall'altro, l'impoverimento della già fragile rete degli ammortizzatori sociali, proprio quando gli effetti devastanti della crisi raccomanderebbero di rafforzarne gli argini. Su tutto ciò, la latitanza del sindacato è di un evidenza solare. E sarebbe disdicevole se la neonata, meritoria attenzione sul fisco servisse a spostare l'attenzione dal rapporto, immediatamente dato, fra capitale e lavoro. Va da sé che un'assunzione di responsabilità, una profonda revisione di cultura, modelli, strategie rivendicative si imponga, a partire dalla più grande confederazione di lavoratori, attesa ad uno dei congressi più impegnativi della sua storia recente. D'altra parte, il fatto che tutta la contesa politico-elettorale si possa permettere di non sfiorare neppure tangenzialmente questi problemi, non rivela forse, più di ogni chiacchiera, la totale ininfluenza dei lavoratori sull'agenda politica del Paese? Sempre ieri, Vincenzo Visco, chiamato da Corradino Mineo a commentare le parole di Bonanni, si è detto più che convinto dell'urgenza di un intervento che attenui il peso tributario esorbitante storicamente accumulatosi sul lavoro. Bene. C'è semmai da domandarsi perché, quando il centrosinistra ne ha avuta l'opportunità, ha agito sul cuneo fiscale per ridurne il peso solo ed esclusivamente dal lato dell'impresa, mentre ha destinato al sistema degli ammortizzatori sociali risorse talmente risibili da risultare insufficienti persino per la manutenzione ordinaria di quegli istituti. Ora Tremonti ha annunciato un intervento organico sul fisco. Tocchiamoci, perché l'uomo ci ha abituato a togliere ai poveri per dare ai ricchi. Ma quand'anche una riduzione delle imposte alleviasse le condizioni dei ceti più deboli, bisognerà compensarla con un aggravio del carico sui piani alti dell'edificio sociale. Altrimenti tutto si ridurrà in un ulteriore depauperamento del welfare ed in una ancor più spinta esternalizzazione e privatizzazione dei servizi sociali, ridotti a merci da acquistare sul mercato. Di questo dovrebbero parlare - facendosi capire dagli elettori - le forze che in queste settimane definiscono il quadro delle alleanze con cui si contenderanno il governo delle regioni. Ma non è così. Le geometrie elettorali, le logiche politiciste sono di gran lunga prevalenti e il Pd sembra esserne prigioniero. Ma c'è un prezzo politico che inesorabilmente si paga a tanta disinvoltura tattica. Quando l'alleanza con l'Udc di Casini - perseguita ad ogni costo e mettendo in conto la recisione di ogni rapporto a sinistra - dovrà trasformarsi in concrete opzioni programmatiche, se ne vedrà sino in fondo il carattere tutt'altro che alternativo alla gestione affaristica e socialmente iniqua a cui ci si continua a dichiarare - con sempre meno credibilità - alternativi.
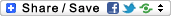
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago