Intanto, un ringraziamento non formale al Presidente Bracco per la convocazione di questa conferenza. Poi, un po’ paradossalmente, un rilievo da muovere proprio nei confronti di chi, a quattro anni dalla sua costituzione, ha preso questa decisione. Dato che noi dovremmo essere in primo luogo rispettosi delle regole che ci siamo dati - e quelle contenute in uno statuto regionale sono le massime regole per la vita dell’istituzione Regione -, non possiamo in questa sede non interrogarci del perché per tanto tempo questo organismo non sia stato convocato, senza che praticamente nessuno abbia sollevato obiezioni. È chiaro che qualcosa non va.
Consentitemi una battuta: in natura esistono degli organismi che muoiono nascendo, non vorrei che ci trovassimo in una simile condizione. Per scongiurarla credo che dobbiamo ripensare i criteri e i metodi con i quali far vivere ed operare questo importante luogo di confronto. A partire dalle modalità con le quali viene e può essere attivato e dal regolamento che lo norma. Tenuto conto che questa è una sede fondamentale per trovare il giusto punto di equilibrio, all'interno di una condivisa pratica della concertazione, fra il ruolo dell'esecutivo e il massimo organismo istituzionale di rappresentanza della Regione, il Consiglio, tanto è doveroso riconoscere al Presidente l'iniziativa che ha preso, quanto dovremmo riflettere sul fatto che una tale inadempienza non abbia a ripetersi.
Naturalmente, il ringraziamento per aver reso possibile questa occasione di discussione è ancora più convinto perchè viene in un momento particolarmente complicato della vita del Paese e della Regione. Noi abbiamo bisogno di una discussione seria, vera e aperta, assolutamente non contingente né piegata alla contingenza. Altrimenti il rischio è che nel passaggio che stiamo attraversando, quella che stamattina è stata evocata come la “classe dirigente” dell’Umbria, non sia in grado di assolvere il compito al quale è chiamata.
Troppo grande e alta è la sfida che abbiamo davanti; la dobbiamo affrontare con una operazione di verità, come spesso ci diciamo fra di noi, sulla condizione dell’Umbria e sulla crisi che la sta attraversando, anche in relazione alla crisi più generale che colpisce il Paese e le economie mondiali più sviluppate. E la dobbiamo superare sforzandoci di guardare al futuro e alle scelte che saremo chiamati a prendere da oggi in avanti.
Il punto, infatti, non è ragionare e discutere tra di noi su dove siamo arrivati o su dove avremmo potuto essere se avessimo fatto scelte diverse. Una discussione di questo genere se ha un senso, e secondo me non lo ha, ce la saremmo potuto permettere se ci fossimo trovati in una transizione ordinaria; oggi invece siamo in uno scenario assolutamente straordinario.
Noi continuiamo a sostenere che l’Umbria ha fatto sicuramente bene su molti fronti, spesso ce lo ripetiamo, altre volte viene messo in rilievo in studi e indagini realizzati da soggetti diversi. Abbiamo sicuramente fatto bene sul versante dell’attivazione delle risorse e della capacità di spesa, della abilità a costruire un contesto attrattivo soprattutto per alcuni tipi di investimenti; abbiamo fatto molto bene sul piano di una tenuta della coesione sociale; abbiamo, tutto sommato, un buon livello di funzionamento della Pubblica Amministrazione, in particolare della sanità; abbiamo saputo contenere il carico fiscale sulle persone e sulle imprese; abbiamo saputo sviluppare un'azione sicuramente efficace, anche se non pienamente utilizzata, volta a valorizzare il capitale umano, la formazione, i percorsi della conoscenza.
Eppure, già in questo contesto nel quale abbiamo cercato e saputo fare cose di pregio prima dell'esplodere della crisi del settembre 2008, non siamo riusciti, o per lo meno abbiamo stentato, a dare un progetto di sviluppo all'Umbria che potesse consentirle di discostarsi significativamente e in positivo dal modello del paese. E' vero, scontiamo dei limiti - ce lo ripetiamo continuamente, senza trinceraci dietro un atteggiamento reticente – ad esempio il tasso di lavoro precario, il deficit di produttività, i salari e le pensioni mediamente e significativamente più bassi di quelli del centro nord, la frammentazione delle imprese, la natura di investimenti più incrementali che strutturali, una visione più a breve periodo che non di lungo respiro da parte della classe imprenditoriale, le debolezze ormai ataviche di imprese poco e mal capitalizzate, le carenze infrastrutturali.
Tuttavia, oltre ciò, penso che non siamo riusciti, pur operando positivamente, a discostarci, come dicevo prima, dal modello in crisi del Paese, anche ed essenzialmente per altre ragioni. Perché troppo pochi sono i margini per agire senza una politica complessiva del Paese che segni una profonda modifica degli orientamenti attuali e così siamo destinati ad essere in gran parte quello che sarà l’Italia nel suo complesso. Probabilmente, è un ragionamento che può avere qualche eccezione, se penso alla Lombardia, al Veneto, all’Emilia Romagna. Ma noi, regione di piccola dimensione, siamo comunque significativamente e inesorabilmente segnati da questa condizione. È successo quello che è successo perché senza una sponda nazionale e una proiezione europea non è possibile che nascano eccellenze capaci di farsi e fare sistema e che siano in grado di trainare complessivamente l’asse di sviluppo di una realtà regionale. Non è successo quello che noi abbiamo auspicato perché il nostro sistema manifatturiero, molto condizionato dalle esternalità, è destinato a seguire - più nella cattiva sorte che nella buona - quelli che sono gli andamenti dei grandi comparti nazionali. Basta vedere quello che sta avvenendo nella chimica a Terni. Non si tratta di qualcosa di diverso rispetto a quello che, purtroppo in negativo, accade nel paese in quel settore assolutamente strategico del manifatturiero avanzato. Considerazioni analoghe possono essere fatte per l'automotive che, pure in presenza di una subfornitura di eccellenza e di alta specializzazione in alcune aree dell’Umbria, rischia un serio processo destrutturazione e ridimensionamento. Soprattutto se l'Italia non riuscirà a darsi un credibile progetto per essere protagonista in quello che si profila come il più globale e profondo riassetto organizzativo e produttivo di un comparto fondamentale per un Paese che vuole dirsi e considerarsi industriale, appunto quello dell’automobile. Anche per quanto riguarda gli elettrodomestici, penso alla vicenda della Antonio Merloni, è del tutto evidente che quanto si sta verificando nel nostro territorio regionale, è sì conseguenza di un serio deficit di capacità imprenditoriale, ma discende anche dal fatto che l'Italia sconta una evidente sovracapacità produttiva senza che al contempo si sia data una strategia di innovazione e internazionalizzazione adeguata alla nuova fase di competizione globale che si è aperta. È successo quello che è successo anche perché le piccole dimensioni e i disegni di riforma fiscale e istituzionale pongono un grande problema all’Umbria. Dobbiamo esserne consapevoli e conseguentemente cercare di ragionare in modo diverso da quanto abbiamo fatto nel passato. Sono convinto che la retorica del “piccolo è bello” non regge più. Oggi chi è piccolo ha possibilità di resistere solo se è in grado di cooperare e fare sistema. Ciò presuppone la necessità di rimettere in discussione un modo e un approccio che, anche culturalmente, sono stati alla base del più grande processo di sviluppo e modernizzazione di questa regione: la dinamica eterogeneità territoriale, la parcellizzazione e la scomposizione produttiva, la capillare pervasività della piccola e micro imprenditorialità sono stati, insieme, elementi virtuosi che hanno permesso all’Umbria di arrivare, in un’altra fase e in un’altra condizione, a conquistare traguardi assolutamente lusinghieri in termini di sviluppo economico e sociale.
Oggi non è più così. Non è più pensabile parlare di competitività tra e dei territori, tra e delle regioni, se non abbiamo una concezione di “territori” e di “regioni” che abbia a riferimento “l'alfabeto europeo”. E per l’Europa e per il mercato mondializzato, parlare in questi termini significa fare riferimento a realtà, entità notevolmente più grandi, più strutturate e quindi capaci di sostenere le nuove sfide del mercato globalizzato.
Per questo il nocciolo della questione che dobbiamo saper affrontare è quello che può riassumersi nel concetto sul quale insisto da un po' di tempo: non basta fare meglio quello che abbiamo fatto bene fino ad oggi, siamo chiamati a fare inevitabilmente cose diverse. E la necessità di cambiare non sta principalmente nell’insufficienza o nei limiti che abbiamo mostrato nel passato, ma nel fatto che di fronte a noi c'è una sfida nuova e terribilmente complessa. Qui vedo il senso e il cuore di una discussione che la classe dirigente dell’Umbria è chiamata ad affrontare. Oggi chi deve svolgere questo ruolo ha il dovere di elaborare e proporre un progetto per il futuro dell’Umbria; di un’Umbria da pensare e da immaginare oltre la crisi. Non arrovelliamoci in discussioni futili come quella sulla discontinuità. Che è una esigenza, è nelle cose. Come si può essere “continuisti” di fronte a una così profonda rottura dei paradigmi dell’organizzazione sociale, economica e produttiva che abbiamo conosciuto in questi anni? Per questo il grande sforzo che dobbiamo compiere è dare corpo ad un'idea possibile e praticabile sul futuro del Paese e di questa regione. Naturalmente, e ovviamente, conta la condizione di partenza e la cognizione di dove siamo e di cosa siamo.
L’Umbria e il suo posizionamento, a mio modo di vedere, sono temi ormai abbastanza indagati. Provo a dire, anche eccessivamente indagati. E qualche volta l’eccesso di osservazione di se stessi mi fa tornare in mente una bella immagine di un romanzo di Heinrich Böll: il mimo che di fronte allo specchio, tutte le mattine, guardandosi e fissandosi in continuità, nella meticolosa opera del trucco, finisce per perdere e perdersi nella sua immagine fino a non riconoscersi, a vedersi riflesso un viso ed una persona non conosciuti. Noi dobbiamo, credo, relativizzare i momenti e distaccare i punti di osservazione su noi stessi. Lo dico anche in relazione alla discussione che stiamo facendo. Se qualche volta, invece di analizzarci e metterci a verifica solo dal nostro interno, lo facessimo fare anche dall'esterno, da soggetti altri, forse riusciremmo anche ad avere qualche stimolo, qualche sollecitazione che può aiutarci ad intraprendere quella strada dell'innovazione che siamo più portati a predicare (per gli altri) che a praticare (per noi stessi). Perché la via del cambiamento ha troppe volte un punto di criticità difficilmente superabile, quello che investe e mette in discussione il ruolo e la funzione (ed anche le rendite di posizione) di chi, più per retorica che per convinzione, la teorizza. Qui si annida l'insidia della “natura” al conservare, qui trova motivazione e spiegazione l'inclinazione di un Paese ed anche di una regione ad atteggiamenti e scelte più “replicanti e adattativi” che veramente innovativi.
Che fare quindi?
Prima di tutto assumere in noi una condizione che vorrei cercare di condividere senza partire esclusivamente dal punto di vista del sindacato e della Cgil in particolare.
Ho letto giorni fa un’intervista di Guidalberto Guidi, membro della giunta nazionale di Confindustria e più recentemente quella di Morandini, Presidente delle Piccole Imprese di Confindustria. Proprio interloquendo e ascoltando tanta parte del sistema imprenditoriale si ha la percezione di quanto sia difficile e piena di incognite la crisi che stiamo attraversando. Analisi, preoccupazioni, toni, del tutto analoghi a quelli del sindacato, da tempo impegnato ad evidenziare la drammaticità della situazione. Per quello che esprimono e rappresentano i numeri che ci sono stati presentati stamattina e per l'oggettiva gravità delle condizioni dei lavoratori nel vertiginoso aumento di precarietà, cassa integrazione, disoccupazione. Mai come in questo momento c’è una sostanziale concordia di stati d'animo e valutazioni sulle incognite del futuro che tiene insieme la pluralità dei soggetti sociali.
Da qui dobbiamo partire; siamo di fronte a una crisi che non è affatto finita, che è difficile, incerta e che pone grandi problemi sociali, economici e occupazionali. Una crisi che dobbiamo ancora attrezzarci ad affrontare adeguatamente, piuttosto che cercare semplicemente di esorcizzare o negare. Faremmo male al Paese ed alla nostra regione, anche se la discussione che stiamo facendo in Umbria non ha certo l'obiettivo di negare le difficoltà e la pessima congiuntura che abbiamo di fronte.
I fatti e la realtà, purtroppo, in questo caso sono molto più duri delle supposizioni, dei tanti vaticini o auspici che si sentono in giro. E se c’è un punto di accordo su questo, se noi abbiamo contezza di quanto sia non scontato l’approdo del passaggio che stiamo vivendo, allora le scelte che dobbiamo fare in questo momento devono avere l'ambizione di pensare, progettare, costruire e indirizzare oggi, dentro la crisi, l’Umbria che vogliamo oltre la crisi. Non possiamo limitarci a resistere, ma mettere in campo il coraggio che serve, sapendo ovviamente che i margini di rischio, anche di insuccesso, possono essere oggettivamente maggiori. Quindi dobbiamo avere la determinazione di segnare orizzonti nuovi, mettere a punto attrezzi e risorse, darci un metodo di discussione e di confronto.
Su questa base penso sia utile una riflessione sul Patto. Ho sentito cose interessanti sulle quali in gran parte concordo. Mi limito a dire, per quanto mi riguarda, che uno strumento non può mai essere un fine in sé, bensì si legittima per i risultati che dà.
E' bene, perciò, che si vada in chiaro su questo aspetto: il Patto vive di contenuti, se dà risultati, se pensiamo che sia qualcosa di utile per conseguire obiettivi insieme prefissati. Concertare, per il sindacato, significa costruire insieme, nell’ambito di un rigoroso esercizio dell’autonomia dei singoli soggetti, le soluzioni che servono. Costruire insieme e autonomamente, sapendo che a un certo momento si smette di discutere e si devono prendere decisioni.
Questo è il senso e il valore della concertazione alla quale, per la C.G.I.L., non ci sono alternative, pur sapendo che anch'essa ha bisogno di essere adattata alle condizioni nelle quali viene utilizzata.
Oggi c’è da riflettere su queste condizioni: o la concertazione viene considerata da tutti come prassi ordinaria del confronto tra le parti, oppure è evidente che si possono manifestare dei seri problemi. La concertazione deve essere una metodologia organicamente assunta e diffusa nelle modalità di rapportarsi e di riconoscere il ruolo dei corpi intermedi.
Penso che la concertazione nel luogo più naturale ed agito, il tavolo generale del Patto, abbia sostanzialmente funzionato, mentre mi sembra che a scendere, tanto per la stessa giunta regionale, quanto per gli altri livelli istituzionali e sul versante territoriale e/o locale, ben più di qualche seria disfunzione si sia ripetutamente manifestata. Non mi pare proprio che la cultura della concertazione sia univocamente e universalmente considerata messa a valore dal sistema istituzionale dell'Umbria e se a questa situazione non si pone rimedio è il complesso dell'impalcatura che rischia di non reggere più.
Oltre il metodo, siamo chiamati, come già detto, ad opzioni di merito sicuramente non semplici, nella consapevolezza che c’è la necessità di renderle utili ed utilizzabili anche per cambiare i segni e i tratti delle politiche del governo del Paese. Dobbiamo avere l’ambizione di giocare un ruolo nazionale, anche dalla nostra posizione di piccola regione, dando l'esempio di ciò che può e deve essere fatto per trovare soluzioni ai nostri problemi. Mi è già capitato di affermare, anche in modo un po’ provocatorio, che per superare questa crisi non basta mettere in campo esclusivamente ammortizzatori sociali e credito, perché limitarsi a questo significa mettersi sulla trincea della pura resistenza; che serve ma non basta. Penso, invece, che bisogna resistere per conservare ciò che serve, resistere per innovare quello che è necessario, resistere per pensare il futuro di cui l’Umbria ha bisogno. E quando parlo di pensare il futuro, parlo di prendere decisioni che devono essere così ambiziose ed impegnative da farci percepire persino i limiti della nostra adeguatezza. Solo se ci sentiamo sollecitati ad interrogarci su quanto siamo adeguati, possiamo anche misurare l'efficacia dei nostri sforzi per promuovere l’innovazione necessaria.
Certo, in questo momento, dobbiamo essere in grado di stare vicini ai lavoratori e alle imprese; dobbiamo mettere in sicurezza il nostro sistema di welfare, consci del fatto che la crisi finanziaria colpisce duramente anche gli enti locali. Ne ho sentito parlare poco nella discussione che stiamo facendo, ma quello che si va prefigurando è una vera paralisi finanziaria del sistema delle autonomie locali. Altro che federalismo! Altro che prerogative delle istituzioni locali! Siamo di fronte al pericolo che il presidio più forte della nostra coesione sociale non abbia più in questo momento margini per esercitare ruolo e funzioni prerogative che siano in grado di rispondere ai bisogni laddove si manifestano e devono essere soddisfatti.
Taglio dei trasferimenti agli enti locali, federalismo fiscale, caduta del Pil, aumento dei disagi sociali per effetto della crisi economica; tutto questo significa che avanti a noi abbiamo il grande compito di preservare la capacità di tenuta del nostro welfare, perché questi quattro elementi se non modificati nella loro impostazione e non accompagnati da una radicale e strutturale riorganizzazione dello stato sociale, probabilmente non ci consentiranno di preservarne i caratteri di moderna universalità e accessibilità.
Peraltro, dobbiamo affrontare un'altra questione di cui si è parlato anche in questa sede; l'ammodernamento e l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali.
Credo che occorra partire dalla constatazione di un evidente pericolo, quello che la crisi possa perdurare ben oltre la possibilità di continuare, stanti le norme attuali, ad utilizzare queste tutele a favore dei lavoratori. Si sta pericolosamente sottovalutando questa, purtroppo sempre più plausibile, eventualità.
Ridare fiducia e speranza al Paese significa in qualche modo rispondere all’emergenza. Come si può consentirgli nuove prospettive, se centinaia di migliaia di lavoratori rischiano di non avere né posto di lavoro né protezione sociale? Per un modello di ammortizzatori sociali organico che protegga universalmente tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di attività, è fondamentale un Paese solido, competitivo, efficiente, che produca ricchezza, capace di reimmettersi virtuosamente sulle vie di un nuovo sviluppo.
Temo purtroppo che se non si arresta la tendenza in atto, impoverimento del sistema produttivo e depauperamento della coesione sociale siano destinate ad essere le due facce distinte della stessa medaglia. Su questo aspetto è bene ragionare con attenzione, anche nella nostra regione. Occorre aprire subito una discussione per tentare di rimuovere regole e strumenti che non servono nella crisi e tanto meno per superarla. Non possiamo più essere un Paese che ha una politica industriale e un mercato del lavoro “a la carte”, con oltre 100 meccanismi di incentivi alle imprese e 40 diverse tipologie giuridiche di rapporto di lavoro. Non possiamo più semplicemente consegnarci a regole europee che impongono vincoli e condizionamenti che conducono ad esiti esattamente opposti a quelli che ci servono per sostenere, salvaguardare, riorganizzare il nostro patrimonio produttivo manifatturiero. Che si badi, ha caratteristiche e connotati unici in Europa e quindi necessita di strumenti mirati e specifici. Possono, norme pensate per tempi normali e che si ha la pretesa di applicare uniformemente a realtà profondamente diverse fra di loro, essere in grado di farci uscire diversi e migliori dalla crisi nella quale versiamo?
Quando la C.G.I.L. sollecita anche la Regione ad aprire una discussione su questo tema, non lo fa per spirito polemico, per sollevare speciosità, ma perché avverte il bisogno di riordinare una “cassetta degli attrezzi” che è divenuta largamente inservibile. Oggi occorre una politica industriale capace, con tempestività, di accompagnare, orientare, aiutare, incentivare in modo mirato le tante imprese e con loro i tanti lavoratori che hanno bisogno di essere difesi e rassicurati.
Una regola come l’87.3C, per come è concepita, ha ancora una validità? Si può ripensare il concetto e il criterio di intensità d'aiuto in ragione degli sconvolgimenti produttivi in atto? Prendiamo il caso dell’Antonio Merloni: resto convinto che sia il cuore e l’emblema della crisi produttiva nella nostra regione. Da come sapremo affrontarla e risolverla discenderà in gran parte il giudizio sulla classe dirigente dell'Umbria. E allora, quali strumenti abbiamo in mano in questo momento per poter costruire un pacchetto localizzativo che sia in grado di attrarre investimenti, in un contesto nel quale trovare un imprenditore che investe è più difficile che trovare acqua nel deserto? E' evidente che quello che si riesce a mettere a disposizione su questo piano può essere un elemento assolutamente decisivo. Ancora, possiamo ripensare il concetto di selettività degli interventi, in una situazione nella quale è selettivo il mercato, è selettiva la competizione, la selezione è nella crisi ed ha uno stampo inesorabilmente darwiniano? Possiamo pensare che quello che mettiamo a disposizione delle imprese, e quindi della salvaguardia occupazionale, invece che accentuare la selezione miri prioritariamente a sostenere una innovazione capace di accompagnare il sistema produttivo oltre la crisi attuale?
Infine, penso anch'io che l'Umbria debba assolutamente accelerare un'azione di riforma interna del suo modello organizzativo e del suo assetto istituzionale. Concordo su molte cose già dette, in particolare sul fatto che l'Umbria possa divenire terra di cerniera dell’Italia centrale. Dobbiamo sentire profondamente questa necessità e questo compito. Il Paese è fortemente percorso da tensioni laceranti; o lo tiene insieme, anche fisicamente, quel pezzo di Italia centrale, portatrice di un modello sociale ed economico diverso, tanto da quello del nord (dal profilo evidentemente egoistico e neocorporativo) quanto da quello del sud (tendenzialmente assistito), oppure può inesorabilmente spezzarsi. L'Umbria può e deve essere, insieme alle altre regioni contermini, un soggetto che aggrega. Ma per trovare la forza di assolvere a questo compito dobbiamo anche superare definitivamente i limiti strutturali che continuano ad affliggerci e vincolarci. Riordinare e semplificare il modello istituzionale; riorganizzare il sistema dei servizi locali; riorientare l'asse dello sviluppo verso la sostenibilità, la valorizzazione ambientale e l'economia verde; efficientizzare ulteriormente il servizio sanitario regionale; ripensare, alla luce dei nuovi bisogni, il welfare locale. Sono considerazioni che facciamo e siamo portati a condividere da tempo. Ma ora di tempo è possibile che non ne rimanga molto a nostra disposizione. Siamo un elastico tirato al massimo della sua capacità di estensione, o ci mettiamo sulla strada di un vero e sostanziale processo riformatore, oppure si può compromettere il futuro dell'Umbria.
Sono questi i temi sui quali sarà messa a prova la credibilità e l'affidabilità di chi si candiderà a governare questa regione. Penso che ce la possiamo fare, l’Umbria ha le qualità e le risorse per guardare con fiducia oltre la crisi che la sta segnando. A patto, però, che sappia affrontare le sfide davvero complesse che l'attendono, con il coraggio di guardare la durezza della realtà e la lungimiranza di mirare lo sguardo in avanti. Pensare cioè a quello che dovremo diventare, piuttosto che a quello che siamo stati.
Manlio Mariotti
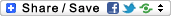
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago