Claudio Cippitelli*
Cocaine. Cocaina al plurale. La stessa sostanza sembra accompagnare tante vite comuni, scandendone l'esistenza tra un pranzo con i genitori e una settimana in ufficio, ma anche vite già segnate da altri abusi, da altre dipendenze. Conosciuta e apprezzata da molti giovanissimi come mai era successo nel nostro paese, si può cercare, e trovare, praticamente ovunque. Da anni le équipe impegnate in attività di prevenzione e riduzione dei rischi nei contesti del loisir notturno andavano affermando che lei, la cocaina, era diventata la vera regina del week-end, navigando trasversalmente attraverso le età, le condizioni socioeconomiche, il genere. Gli stili di assunzione che appaiono a questi operatori sono molti diversificati, coprendo tutto lo spettro delle possibilità, dal consumo sporadico e/o occasionale di carattere ricreazionale sino alla compulsività, nella ricerca della sostanza e nell'uso, di coloro che manifestano forti problematicità e dipendenza. Dalla metà degli anni Novanta, accanto alla diversificazione dei contesti notturni, non più centrati sulla discoteca e estesa sino alle micro aggregazioni dei festini in case private, si è assistito alla assunzione di centralità della cocaina nei policonsumi, senza che questo fenomeno imponesse un adeguamento dei Ser.T. per affrontare i nuovi bisogni di assistenza, né un potenziamento di quelle attività di prevenzione, contatto e riduzione del danno che possono garantire adeguatezza e tempestività di risposta proprio laddove i consumi di cocaina avvengono.
Accanto alla cocaina del loisir, dei giovanissimi, degli ultraquarantenni ancora in famiglia o con famiglia, esiste la cocaina in vena, nuova sostanza primaria di molti tossicodipendenti già da eroina. Di certo, molti tossicodipendenti che trovavano nell'eroina forme di compensazione, con la coca scompensano, hanno atteggiamenti aggressivi e a volte deliranti, hanno una percezione del rischio pari a zero, con una bassissima cura di se. Inoltre non si sa bene cosa fare quando stanno male, in assenza di un omologo del naloxone, che risolve molti casi da overdose da eroina. (Per una trattazione più completa si veda: Claudio Cippitelli, "Consumi al plurale", in Fuoriluogo , supplemento mensile de Il Manifesto , 27 febbraio 2004).
Emersione, altro che emergenza. Sequestri giornalieri: dosi in palline per studenti, professionisti, operai, rinvenimenti eclatanti di tonnellate di coca nei tir che traversano la nazione. Inchieste giornalistiche, speciali televisivi; il mondo dello spettacolo e della politica coinvolti, con un clamore sempre più privo di stupore, consumo che si fa routine, mainstream, luogo comune. Convegni delle più importanti società scientifiche, ricerca di nuove metodologie nelle terapie, annunci di vaccini in grado di risolvere la questione. Quale questione? L'emergenza cocaina.
Clamore senza stupore. La pandemia di consumi di cocaina, l'abbassamento dell'età di consumo, l'innalzamento dell'età dei consumi, nei maschi come nelle femmine, coca tirata da nasi abituati al tannino da 50 euro la bottiglia come da nasi che si accontentano del vino in cartone. L'emergenza, la scoperta di un paese che è in sintonia, che ha consuetudine con una delle droghe più presenti nella letteratura, nella musica, nel cinema, insomma nella cultura del Novecento e ora degli anni 2000. La cocaina: non c'è forse sostanza psicotropa, se si eccettua l'alcool e il superalcool, che possa godere di buona stampa come la polvere derivata dalle foglie di coca.
La tragedia dell'insufficienza. La tesi di Alain Ehrenberg (Sociologo, dirige il gruppo di ricerca Psychotropes, Politique, Société del Cnrs) sembra fornire strumenti esplicativi assai convincenti: «L'azione si è oggi individualizzata. Fa capo a un soggetto, un agente, che la effettua e ne è l'unico responsabile. Oggi, si può dire, è l'iniziativa individuale il primo parametro di valutazione del valore di una persona (…). Insomma, le regole appaiono radicalmente mutate, qualunque sia il settore - impresa, scuola, famiglia - preso in esame. Non più obbedienza, disciplina, conformità all'etica corrente, bensì flessibilità, spirito di cambiamento, rapidità di adattamento, ecc. Padronanza di sé, duttilità psichica e affettiva, capacità di azione/reazione fanno in modo che ciascuno si senta in dovere di adeguarsi in permanenza a un mondo che sta appunto perdendo la sua permanenza, un mondo instabile, provvisorio, con fluissi e traiettorie sobbalzanti come i tanti denti di un ingranaggio perverso. Anche la leggibilità dello scenario sociopolitico è offuscata. Queste trasformazioni istituzionali trasmettono una sensazione di confusione, la sensazione che tutti, anche i più umili e sprovveduti, si debbono assumere l'onere di scegliere tutto e decidere tutto» (Alain Ehrenberg, La fatica di essere se stessi , Einaudi, 1999).
Il sociologo francese evidenzia come la contrapposizione, valida sino agli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso secolo, tra ciò che è permesso e ciò che è vietato è stata ormai sostituita, nella mente dell'uomo occidentale, dalla scelta alternativa tra ciò che risulta essere possibile e ciò che è ritenuto (per ora) impossibile.
All'affievolimento della nozione di divieto fa seguito la riduzione drastica del ruolo della disciplina nelle forme di regolazione del rapporto tra individuo e società, forme, dice Ehrenberg, «che oggi fanno appello più alla decisione e all'iniziativa personali che all'obbedienza disciplinare. La persona non è mossa da un ordine esterno (o da una conformità alla legge), ma occorre che faccia appello a risorse interne, a competenze mentali proprie» (op. cit.).
L'iniziativa è divenuta una regola comune, valida a tutti i livelli societari, e misura ciascuno di noi, descrivendo chi è all'interno di una sorta di "spirito generale" della nostra società e chi ne risulta inevitabilmente emarginato. La patologia che tale assetto societario porta con se è, secondo Ehrenberg, la depressione che «è una tragedia dell'insufficienza: l'ombra anche troppo familiare dell'uomo senza guida, intimamente spossato dal compito di diventare semplicemente se stesso e tentato di sostenersi con l'addittivo dei farmaci o dei comportamenti compulsivi» (op. cit.).
Per molte persone, la cocaina svolge il ruolo di un farmaco, autoprescritto e autosomministrato: «Eludere la depressione è ormai semplice come evitare di rimanere incinta: prendete la vostra pillola e sarete felici» si legge su Lancet nel 1990 ("Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine", in The Lancet , ed. francese, 1990, citato in Ehrenberg, op. cit.); l'autorevole rivista scientifica fa riferimento a quel mercato degli antidepressivi che, a partire dalla metà degli anni Settanta vede un incremento esponenziale, tale da rendere il Prozac il secondo farmaco più venduto in Francia nel 1995. La cocaina segue questa traiettoria nella società italiana e, proprio a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, vede rafforzare la sua quarta posizione tra le sostanze psicotrope consumate (nell'ordine alcol, superalcol, cannabis e cocaina). La presenza della depressione come patologia nello stesso tempo di massa e societaria, rappresenta uno dei possibili fattori esplicativi della straordinaria diffusione dei consumi della cocaina in Europa e in Italia.
Ma non solo: le forme di tali consumi e l'estrema varietà dei cluster sociali coinvolti (distinti per età, genere, ceto, cultura, ruoli…) costringono a non pervenire a inferenze definitive. Anzi, piuttosto che di cocaina, forse occorre parlare di cocaine, al plurale, per descrivere come la stessa molecola possa accompagnare personalità, ruoli e status assai diversi, motivando, come si è visto dai dati, per tanti individui un uso sporadico, per molti un uso frequente; per una percentuale assai più contenuta consumi problematici e dipendenza. Inoltre, è assai significativo il panorama dei consumi nei quali si inseriscono quelli di cocaina: in altre parole, a cosa si giustappone la striscia (alcol e superalcol? Cannabis? Oppio? Ketamina? Eroina fumata? Tutti questi?), o a cosa si sovrappone, cosa sostituisce (eroina iniettiva, nel caso dei dipendenti da oppiacei che si riconvertono alla cocaina, per opportunità di mercato, per la qualità della sostanza…).
Non è la droga solo di chi lavora, né la droga del tempo libero. Anzi, la cocaina aiuta a comprendere come tale distinzione sembra non avere più senso: «La formula magica di Goethe per strutturare la quotidianità all'inizio dell'epoca industriale - "Di giorno il lavoro!/ ospiti la sera!/ Dure le settimane!/ Liete le feste!» - non è più proponibile in un regime di deregolamentazione e fluidità dell'organizzazione del lavoro come quello attuale. Di conseguenza anche la distinzione tra droghe da lavoro, per incrementare la produttività, e droghe da tempo libero, per raggiungere uno stato di benessere psichico, è ormai inutilizzabile» (G. Amendt, No drugs no future, le droghe nell'età dell'ansia sociale , Feltrinelli, 2004).
Nella citazione di Amendt gli individui nella società postindustriale sono lasciati all'autoresponsabilità, e ognuno è in concorrenza con l'altro e tutti lo sono contro tutti (op. cit.). L'autoresponsabilità non si limita, però, solo all'ambito lavorativo: colonizza tutto lo spazio vitale degli individui, compreso lo spazio del loisir, i rapporti interpersonali, quelli tra le generazioni e anche tra i generi.
*Testo rielaborato a partire dal volume In estrema sostanza, scenari servizi e interventi sul consumo di cocaina , a cura di Fabrizia Bagozzi e Claudio Cippitelli, Iacobelli Editore 2008 (pp. 234, euro 15,00)
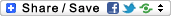
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago