Davide Turrini
Cocaina e cinema. Ripetizione con lo sguardo di un movimento di macchina indotto. Carrellata a destra, o sinistra, per seguire la tirata di coca del protagonista di turno. Direzione inusuale del mezzo, dinamica liberatoria dello spirito, rapida occhiata dello spettatore sulla striscia bianca che appena apparsa scompare. Decine gli esempi tradizionali, due i capisaldi devianti per esemplificare l'assunto. Ray Liotta, alias Henry, in Quei bravi ragazzi (1990, Martin Scorsese) si mette a fare lo spacciatore di cocaina dopo una carriera da blasonato tirapiedi della mafia. Sequenza dopo sequenza, sempre più congestionato dagli effetti della coca, Liotta "pippa" una dose da un tavolino casalingo. Scorsese fa compiere alla macchina da presa un movimento in avanti, a seguire il percorso aereo della cocaina inalata. Non siamo più semplici osservatori dell'atto, ma ne diventiamo brulicante polvere attiva, sorta di urticante soggettiva cocaina. A pari di Liotta sta Al Pacino nei panni del boss cubano Tony Montana in Scarface (1983, Brian De Palma). Scacciato da Cuba, perché come dice Castro ad inizio film «non si è adattato alla nostra rivoluzione», Montana sbarca a Miami e in breve tempo surclassa un boss della droga statunitense, instaura la sua struttura criminale e va a procurarsi la "bamba" direttamente dalla Colombia. Scritto da Oliver Stone (che poi privatamente di cocaina per poco non creperà) Scarface culmina in un massacro dove Montana rimane catatonico a sedere sul trono regale con davanti a sé una montagna di cocaina. De Palma non compie nessun movimento di macchina, ma lascia Pacino immerso in questa massa bianca, dietro la quale ogni tanto scompare per poi riemergere con la punta del naso imbiancata.
De Palma, più di Scorsese, "apripista" della rappresentazione visiva di un soggetto che conferma la sua debordante presenza sociale proprio all'inizio degli anni '80. Poco prima, e contemporaneamente, c'era stata l'eroina; prima ancora l'lsd. Ancora più indietro il "codice Hays". Ovvero quel morigerato libello zeppo di restrittive e puritane linee guida per la produzione cinematografica che ha imperversato nel cinema americano, quindi occidentale, dal 1930 al 1967. Tra divieti di nudo, di rappresentazione dell'omosessualità, di sesso tra razze diverse, c'era ovviamente finita anche la droga. Irrappresentabile fino a quando non prorompono la New Hollywood con Easy rider (1968, Dennis Hopper) a sdoganare gli acidi lisergici e in Europa film come Christiane F. (1981, Ulrich Edel) o Amore tossico (1983, Claudio Caligari) a mostrare in dettaglio le pere di eroina. L'affermarsi della coca in primo piano ravvicinato è questione di pochi anni. Ci aiuta a spiegarlo il monologo iniziale in voce over dello spacciatore di cocaina XXXX (Daniel Craig) nell'inglese The Pusher (2004, Matthew Vaughn): «Negli anni '90 la sniffata di bianca era roba da cantanti rock o feste miliardarie e veniva demonizzata dai lettori della stampa popolare che si sbronzavano di alcool all'osteria: oggi sono loro i miei migliori clienti».
La rappresentabilità cinematografica della cocaina va di pari passo con la sua proletarizzazione sul mercato. Prima esclusivo uso e consumo dei boss della mala che sniffano; successivamente sentita intrusione tra classi sociali più basse. Il nullatenente protagonista (James Woods) del moralisteggiante Cocaina (1988, Harold Becker) parifica la scalata al successo professionale (i prodromi dei subprime immobiliari) all'assunzione compulsiva di coca, facendo andare famiglia e lavoro in malora. Con un occhio l'America hollywoodiana demonizza, mentre con il naso pippa. Se pensiamo all'ancor giovane Robert Downey Jr., uno degli attori più devastati dalla tossicodipendenza di coca, protagonista di Al di là di tutti i limiti (1987, Marek Kanievska), un film che trasforma il romanzo gravido di coca firmato da Bret Easton Ellis in un filmetto sentimentale, comprendiamo l'ipocrisia dello star system statunitense. Non che in Italia possiamo definirci dei rischiosi sperimentatori visivi ed etici. Il tabù rimane solido perfino nell'attimo della sua tanto attesa rappresentazione. Da Johnny Stecchino (1991, Roberto Benigni) dove la si butta in vacca in un compassionevole registro tra demenziale e buonista (ricordate la gag dell'handicappato che sniffa?), fino ad A casa nostra (2006, Cristina Comencini) dove Luca Argentero e Laura Chiatti tirano un paio di righe nel post copula, come se assumessero un calmante per il sonno. Unici esempi realistici e virtuosi sono le pippate dei malavitosi in Romanzo criminale (2005, Michele Placido) o quelle di Tony Pisapia (Toni Servillo) in L'uomo in più (2001, Paolo Sorrentino).
Rimangono aperte le attuali frontiere dove la cocaina scorre a fiumi in mezzo alle figure più impensabili delle nuove città: impiegati, commessi, semplici operai alle prese con cannula e piattino. Il totalizzante Polvere (2007, Massimiliano d'Epiro e Danilo Proietti) dove nemmeno i preti sono esenti dalla sniffata o, uscendo all'estero, la trilogia danese Pusher (1996-2004-2007, Nicholas Winding Refn) e lo spagnolo After (2009, Alberto Rodriguez) triangolo esistenziale donna più uomo condito di disco, sesso, alcol e piste di coca. Difficile continuare a spettacolarizzarne l'uso: la cocaina si consuma a quintali dappertutto. E per coglierne la fenomenologia, al cinema basterebbe uno sguardo neorealista alla Vittorio De Sica.
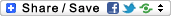
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago