Guido Caldiron
Oltre tredici milioni di europei adulti hanno provato la cocaina almeno una volta, metà di loro ha un'età compresa tra i 15 e i 34 anni e l'Italia si conferma, insieme a Danimarca, Spagna, Irlanda e Gran Bretagna, uno dei paesi dove l'aumento dei consumatori è in crescita costante. Basterebbe una semplice occhiata ai dati contenuti nel Rapporto 2009 dell'Osservatorio europeo sulle droghe, presentato a novembre a Bruxelles, per rendersi conto che la cocaina rappresenta oggi un vero e proprio "fenomeno sociale" e anche di vaste proporzioni. L'exploit di questa sostanza nell'arco degli ultimi vent'anni sembra inoltre configurare una profonda. o comunque rilevante, trasformazione di quella che può essere definita come "sociologia delle droghe", non solo nel senso della diffusione nella società di una determinata sostanza, ma anche dell'analisi del rapporto che questo o quel consumo ha con i valori sociali maggiormente condivisi o dominanti. Alcune recenti pubblicazioni offrono da questo punto di vista preziose indicazioni.
In Cocaina. Consumo, psicopatologia, trattamento , il volume collettivo curato da Paolo Rigliano e Emanuele Bignamini - psichiatra e criminologo clinico il primo, psichiatra e psicologo il secondo - e pubblicato da Franco Angeli (pp. 350, euro 28,00) si mette ad esempio in evidenza il passaggio dalla figura dell'eroinomane, che ha caratterizzato simbolicamente nello spazio pubblico il volto del "tossicodipendente" negli anni Settanta e Ottanta, a quella del coicanomane nel corso degli ultimi decenni. «Dalla mitologia dell'eroinomane come ribelle fallito ed emarginato, segno dell'aria mortifera che appesta la città, alla mitologia del cocainomane come eroe del piacere estremo, trionfante oltre ogni limite e regola, ebbro di potenza e di euforia: ecco il percorso di un capovolgimento prodigioso. - si legge nel primo capitolo del libro firmato da Rigliano e intitolato "Come pensare il consumo di cocaina", che precisa - Transizione da una mitologia all'altra: dalla sconfitta al trionfo, dal dolore silenziato al superamento del disagio, dal malessere alle pretese di piacere, dalla schiavitù della droga alla liberazione da ogni vincolo, ansia, inibizione. Quello cui si assiste è un cambiamento dei modelli di rappresentazione di sé - e di sé in rapporto all'altro. Una metamorfosi radicale degli obiettivi di valorizzazione e di autoaffermazione, che sottende il cambiamento dei paradigmi di senso e di valutazione sociale. Cambiamento delle percezioni, certo: ma questo, allo stesso tempo, indica il cambiamento dei contesti socioculturali, matrice primaria per definire e, prima ancora, per immaginare il proprio valore».
La relazione tra le trasformazioni che hanno attraversato la società e l'emergere di "nuove droghe" - un rapporto non certo esaustivo per motivare i consumi individuali che spesso vedono il sovrapporsi di più sostanze nelle abitudini dello stesso soggetto, ma che può offrire indicazioni interessanti, per quanto necessariamente generiche - è perciò riassunto in questo termini dallo stesso Rigliano, che attualmente dirige un Centro Psicosociale nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale di Milano: «Potenza e disponibilità al rischio, pretesa di trionfare infrangendo confini e norme, espansione e sperimentazione di sé in forme nuove, sfida a se stessi e agli altri: non c'è valore e scopo personale e sociale che non venga vittoriosamente esaltato dalla cocaina. Essa realizza il vivere come affermazione a tutti i costi di sé: illude di essere il mezzo più efficiente per realizzarsi come competitore vincente per il potere. Economia di un desiderio che è legge sociale e valore etico, perché utile a vincere nella competizione sociale. C'è dunque una corrispondenza dialettica tra cocaina e società: essa è davvero la droga ideale, l'emblema dei valori dominanti. Essa li celebra, proponendo al soggetto una partita mortale: "Esercitati a diventare potente grazie a me, vai oltre ogni controllo ma mantieni il controllo, sii vincente oltre i confini ma domina questa trasgressione delle norme e dei limiti". In fondo, è tutto il nostro sistema ad mare follemente il rischio e la sperimentazione, l'incremento e il consumo, lo spreco e la potenza vertiginosa. Allora, la cocaina è un'esperienza personale d'allenamento alla socialità di successo».
Allo stesso modo nell'introduzione a Cocaina, psiche e crimine , riflessione sugli "effetti neuro-psico-sociali della cocaina", pubblicato da Paolo De Pasquali, Aurelia Costabile e Anna Maria Casale per Franco Angeli (pp. 136, euro 17,00), Francesco Bruno spiega come «gli effetti stimolanti della cocaina si sono particolarmente adattati ai bisogni di una società sempre più dissociata e sempre più marcata da necessità di performance al massimo livello in ogni settore ed al bisogno di essere accettati e contemporaneamente far valere la propria personalità. Si tratta di una società "paranoide", del "tutto o nulla", dove l'azione della cocaina tende a sbilanciare verso l'esterno, e quindi verso l'apparire, il significato stesso di ogni relazione interpersonale (...). Mentre si chiudono le porte della propria affettività alla relazione con l'altro, soprattutto se quest'altro ci appare come diverso e lontano dal nostro standard, sull'altro versante si teme che l'altro possa penetrare nel nostro profondo e in qualche modo distruggerlo».
Sociologa e criminologa dell'Università di Bologna, anche Alessia Bertolazzi indica nel volume che ha dedicato alle principali tesi della Sociologia della droga , (pp. 174, euro 17,00), pubblicato sempre da Franco Angeli, una particolare forma di "devianza" nel consumo di cocaina e delle cosidddette "nuove droghe". «Si potrebbe correlare il consumo - scrive Bertolazzi - ad un quadro di "malessere esistenziale", che risente dello svincolamento da legami sociali "forti", della precarietà esperita su più fronti (economico, lavorativo, affettivo), dell'incertezza come condizione di fondo, del mancato raggiungimento del benessere e della realizzazione come individui». Insomma una sorta di «estensione soggettiva per affrontare le esigenze di riuscita, di performance e di autorealizzazione che la società comunque richiede ai suoi membri».
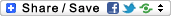
Recent comments
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago
12 years 13 weeks ago